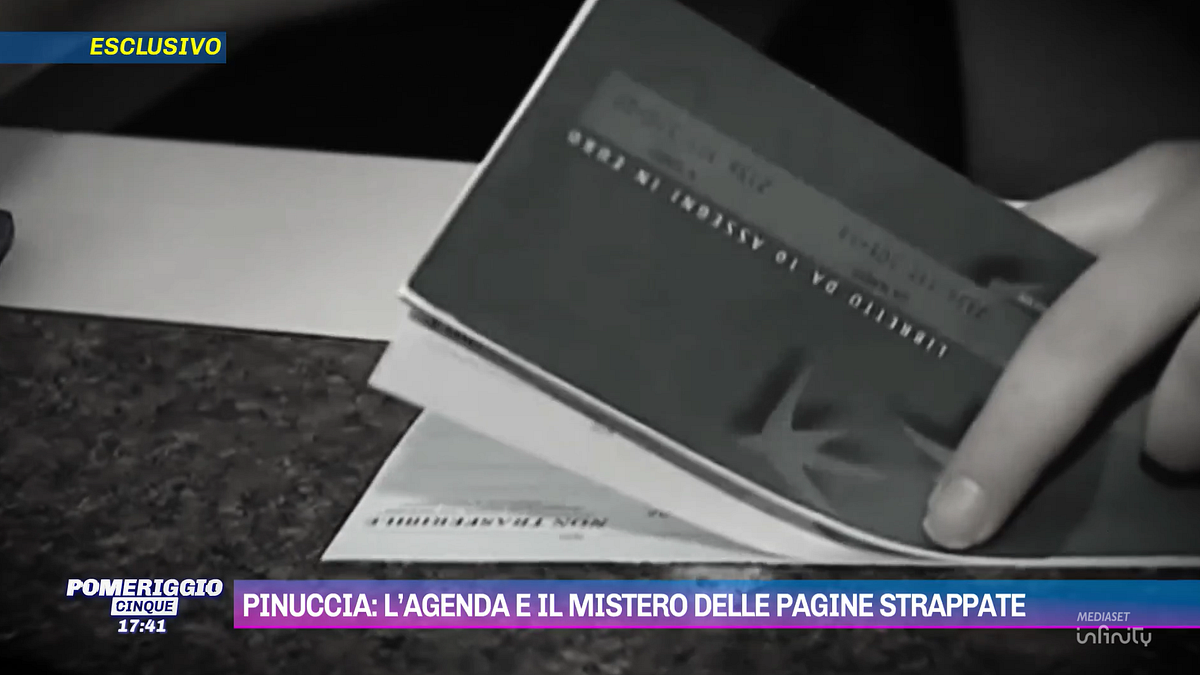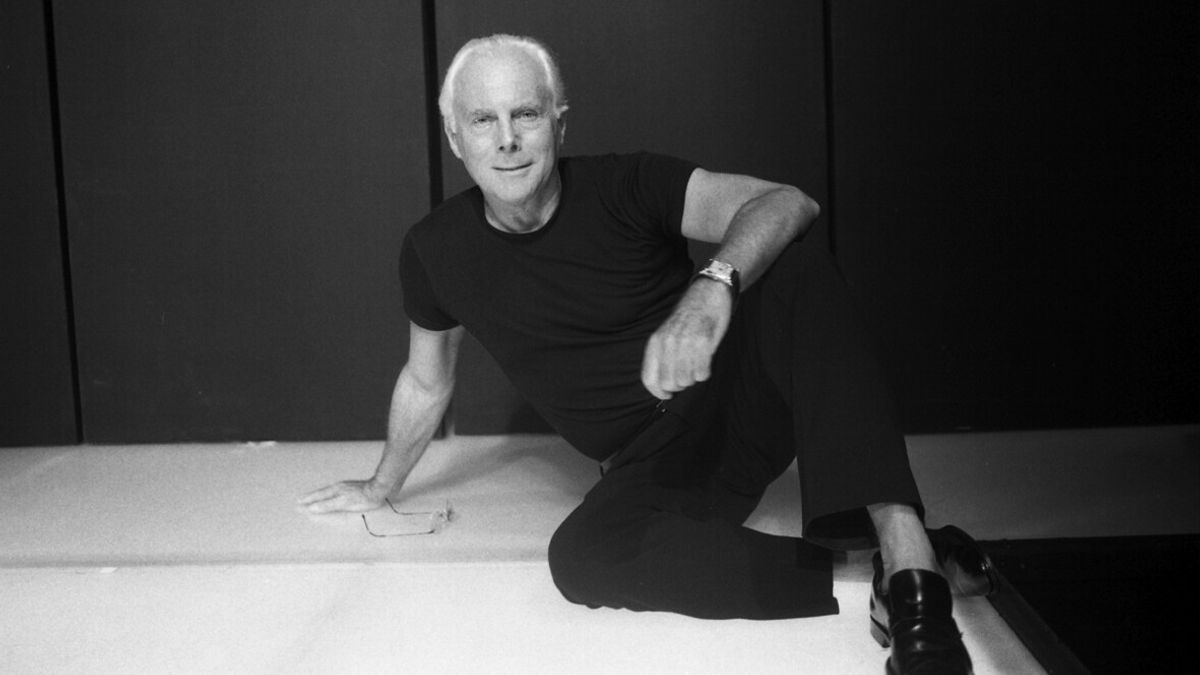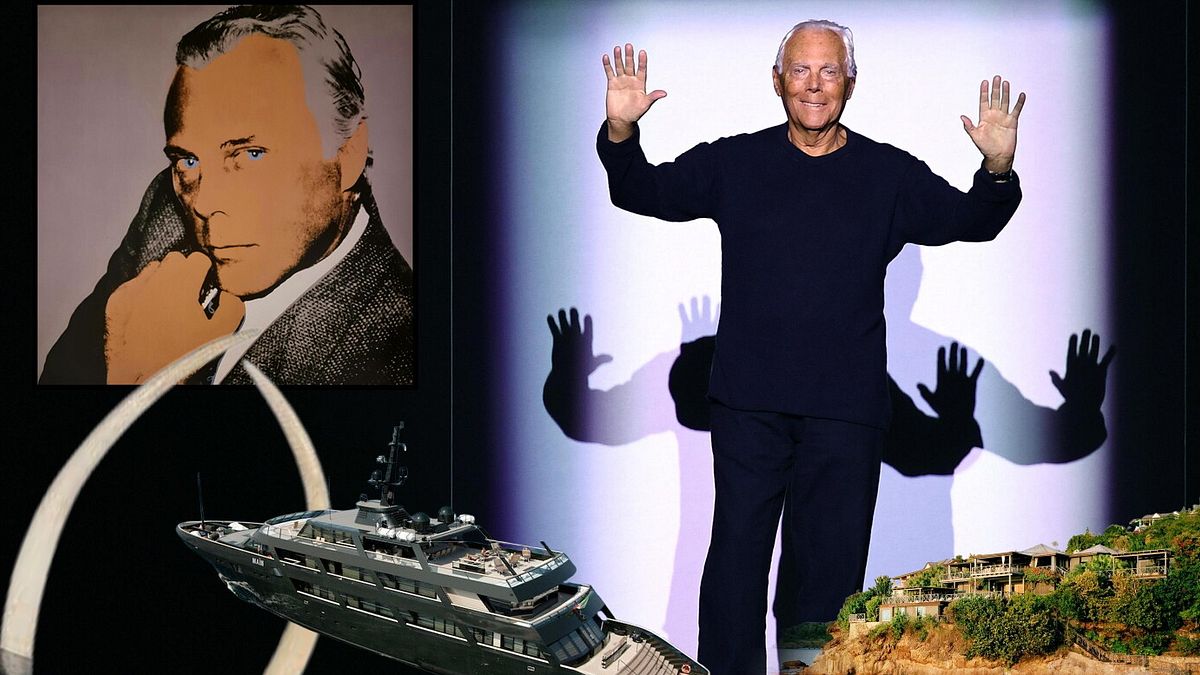A chi lasciare i propri beni se non si hanno figli o altri eredi? L'opzione del testamento solidale
Sempre più italiani scelgono il testamento solidale per dare continuità ai propri valori. Dall'esenzione fiscale totale alla libertà di destinazione: ecco come funziona e chi l'ha scelto

© Istockphoto
In Italia cresce il numero di persone senza eredi diretti. L'invecchiamento della popolazione e il calo delle nascite stanno creando un fenomeno nuovo: patrimoni accumulati in una vita di lavoro che rischiano di finire in mano a parenti lontani mai frequentati o, in mancanza di questi, direttamente allo Stato. Ma c'è un'alternativa che sta prendendo piede: il testamento solidale, la scelta di chi vuole che i propri beni continuino a fare del bene anche dopo la propria dipartita.
È la strada intrapresa dalle gemelle Kessler, Alice ed Ellen, che hanno deciso di lasciare un fondo a Medici Senza Frontiere. Le due showgirl erano già state volto di una campagna di raccolta fondi testamentari per l'organizzazione nel 2014, dimostrando come la beneficenza possa diventare l'ultima, grande eredità di una vita.
Il boom delle eredità solidali I numeri parlano chiaro e confermano una tendenza in forte crescita. Secondo l'indagine "Lasciti solidali, una leva per crescere" condotta dal Comitato Testamento Solidale in collaborazione con VITA su 197 organizzazioni non profit, il 58% degli enti ha ricevuto almeno un lascito tra il 2020 e il 2024. Un dato significativo che sale all'87% tra le organizzazioni con uno staff dedicato e all'89% tra chi ha attivato una campagna di sensibilizzazione negli ultimi cinque anni.
Negli ultimi dieci anni le donazioni testamentarie a favore di organizzazioni no profit sono aumentate del 10-15%. Il fenomeno è in forte crescita, alimentato non solo da ragioni demografiche ma anche da una maggiore consapevolezza. Chi non ha figli o un coniuge si interroga sul destino del proprio patrimonio e trova nel terzo settore una risposta che dà senso a quanto costruito in una vita.
Il trend è particolarmente evidente guardando ai dati recenti: se nel 2020 il 39% delle organizzazioni intervistate non aveva ricevuto alcun lascito, nel 2024 questa percentuale è scesa al 23%. Nel contempo, le organizzazioni che ricevono tra uno e cinque lasciti all'anno sono passate dal 39% al 50%. Il peso dei lasciti sulla raccolta fondi totale è quasi raddoppiato, passando dall'8% del 2020 al 14% del 2024.
Come funziona il testamento solidale Le opzioni per disporre del proprio patrimonio sono diverse e la scelta dipende dalle proprie volontà e dalla situazione familiare. Per chi non ha eredi legittimari, la legge offre piena libertà: si può nominare un amico come erede universale di tutti i propri beni, lasciare un immobile specifico a un parente lontano, destinare una somma di denaro a chi si è preso cura di noi negli ultimi anni. Oppure si può scegliere la via del testamento solidale, indicando una o più organizzazioni del terzo settore come beneficiarie di una parte o dell'intero patrimonio.
La chiave sta nella formalizzazione: senza un testamento scritto, i beni vengono devoluti per legge ai parenti fino al sesto grado o, se non ce ne sono, finiscono allo Stato. Per evitarlo basta un testamento olografo, scritto interamente a mano, datato e firmato, o un testamento pubblico redatto da un notaio. Entrambe le forme garantiscono il pieno controllo sulla destinazione dei propri beni e possono essere modificate in qualsiasi momento fino all'ultimo giorno di vita.
Un dato interessante emerge dall'indagine tra i notai realizzata dal Comitato Testamento Solidale: il 20% dei professionisti dichiara di aver notato una crescita costante delle disposizioni testamentarie solidali negli anni (11,3%) o dopo la pandemia (8,2%).
I vantaggi fiscali C'è un aspetto che rende il lascito solidale particolarmente vantaggioso: l'esenzione fiscale totale. I lasciti testamentari a favore di enti del terzo settore iscritti al registro unico nazionale non pagano l'imposta di successione. Questo significa che l'intera somma o il valore del bene arriva integralmente alla causa scelta, senza alcuna decurtazione.
Al contrario, se si lascia il patrimonio a parenti non stretti o ad amici, si applicano imposte di successione che possono essere significative. Coniuge e figli hanno una franchigia di un milione di euro ciascuno, oltre la quale versano un'imposta del quattro per cento. Per fratelli e sorelle la franchigia scende a centomila euro, mentre l'aliquota sale al sei per cento. La differenza è sostanziale: nel primo caso il proprio contributo ha il massimo impatto possibile, nel secondo una parte consistente finisce nelle casse dello Stato.
Libertà piena per chi non ha eredi legittimari Per capire fino a che punto si possa disporre liberamente del proprio patrimonio bisogna conoscere la differenza tra quota disponibile e quota di legittima, e soprattutto chi sono i soggetti coinvolti. Il testatore è la persona che redige il testamento e decide come distribuire i propri beni dopo la morte. Gli eredi legittimari sono invece i familiari più stretti che la legge tutela in modo particolare: si tratta del coniuge, dei figli e, in loro assenza, dei genitori. Questi soggetti hanno diritto per legge a una parte del patrimonio che il testatore non può toccare.
La quota di legittima è proprio questa porzione del patrimonio che la legge riserva inderogabilmente agli eredi legittimari. Nessuno può privarli di questo diritto, nemmeno con un testamento. La quota disponibile è invece la parte del patrimonio di cui il testatore può disporre liberamente con il testamento, a favore di chiunque: amici, conoscenti, enti benefici o persone care che non rientrano tra gli eredi legittimari.
Il punto fondamentale è questo: se il testatore non ha eredi legittimari, la quota di legittima è zero. Significa avere il cento per cento del patrimonio disponibile, con totale libertà di destinazione. Si può lasciare tutto a un'organizzazione benefica, dividere tra più cause, o combinare lasciti a persone care ed enti non profit secondo la propria volontà. Senza alcun vincolo di legge.
L'indagine del Comitato Testamento Solidale conferma che questa libertà viene molto apprezzata: l'87% dei lasciti ricevuti dalle organizzazioni negli ultimi cinque anni è stato privo di vincoli, lasciando all'ente la libertà di decidere come impiegare le risorse secondo le necessità e le priorità. Solo il 13% era vincolato a specifici progetti o attività.
Un fenomeno trasversale per dimensione e valore Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il lascito solidale non è appannaggio esclusivo di grandi organizzazioni o di persone particolarmente abbienti. La ricerca rivela che il fenomeno è trasversale: anche le organizzazioni con entrate sotto il milione di euro ricevono lasciti (il 34% di esse ne ha beneficiato), sebbene con frequenza minore rispetto alle realtà più grandi (70% per quelle tra uno e dieci milioni di euro, 88% per quelle sopra i dieci milioni).
Quanto al valore dei lasciti, i dati raccolti tra i notai confermano che non si tratta di uno strumento solo per patrimoni consistenti. Per il 46% dei professionisti intervistati, chi predispone un lascito solidale ha un patrimonio nella media, frutto di una normale vita lavorativa. Il valore medio di un lascito si attesta su cifre inferiori ai ventimila euro per il 32% dei notai, mentre per un altro 37% si tratta di importi tra i ventuno e i cinquantamila euro. Per sette notai su dieci, il valore medio di un lascito è inferiore a cinquantamila euro.
Chi sono i testatori L'indagine restituisce anche un profilo dei testatori solidali. Secondo il 60% delle organizzazioni intervistate, i lasciti provengono prevalentemente da donne, mentre per il 25% arrivano in egual misura da uomini e donne. La maggioranza (63%) riguarda ancora persone senza figli, anche se inizia a emergere un cambiamento: il 5% delle organizzazioni afferma che i lasciti arrivano in prevalenza da persone con figli e un altro 12% registra disposizioni nella stessa misura da persone con e senza figli.
Un dato particolarmente interessante riguarda il rapporto pregresso con l'organizzazione beneficiaria: il 25% delle organizzazioni dichiara di ricevere lasciti in prevalenza da persone che non sono state loro sostenitrici in vita, mentre un altro 23% li riceve in egual misura da sostenitori e non sostenitori. Solo il 43% indica che i testatori erano già sostenitori dell'ente. Questo significa che il terzo settore viene percepito da molti come lo spazio attraverso cui lasciare del bene nel mondo, anche in assenza di un legame personale continuativo.
Quando l'eredità va agli animali domestici C'è chi sceglie di destinare il proprio patrimonio al benessere dei propri animali domestici. In Italia non è possibile nominare direttamente cani o gatti come eredi, perché la legge non riconosce loro la capacità giuridica. Tuttavia esistono soluzioni alternative: si può nominare una persona di fiducia o un'associazione animalista come beneficiaria, con l'obbligo esplicito di utilizzare i fondi per la cura dell'animale.
Negli Stati Uniti, dove queste pratiche sono legali, i casi più eclatanti hanno fatto il giro del mondo. Leona Helmsley, magnate degli hotel di lusso, ha lasciato dodici milioni di dollari al suo cane maltese Trouble. Un giudice ha poi ridotto la somma a due milioni di dollari, ma Trouble ha continuato a vivere con una spesa annua di centomila dollari per cure, toelettatura e sicurezza.
Da Raffaella Carrà ad altre star internazionali Non sono solo le gemelle Kessler ad aver scelto questa strada. Raffaella Carrà, icona della televisione italiana scomparsa nel 2021, non avendo figli né coniuge ha devoluto gran parte del suo patrimonio ad amici, parenti e soprattutto a enti benefici da lei selezionati. Una scelta che ha dato continuità ai valori che l'avevano sempre contraddistinta.
Nel mondo dello spettacolo internazionale, George Michael ha lasciato una collezione di opere d'arte e antichità al Mill Charitable Trust, un fondo benefico da lui creato nel 2009. Tra i beni donati figurava anche un pianoforte appartenuto a John Lennon. Robin Williams ha invece disposto un lascito solidale che ha creato un precedente unico: ha lasciato in eredità i diritti sul proprio nome, firma e fotografie alla Windfall Foundation per venticinque anni, con il mandato di destinare gli introiti ad associazioni benefiche internazionali, tra cui Medici Senza Frontiere.
La scelta dei grandi della storia italiana La storia italiana è altrettanto ricca di esempi illustri. Giuseppe Verdi e Alessandro Manzoni si sono posti il problema di come poter compiere un gesto di generosità, senza ledere i diritti dei propri cari. Nel 1900 Verdi decise di destinare i suoi beni agli "Asili Centrali", agli Istituti dei "Rachitici", dei "Sordo Muti" e dei "Ciechi" di Genova, così come all'Ospedale degli Asili e al Monte di Pietà e ai poveri di Busseto, suo paese d'origine.
Camillo Benso Conte di Cavour attribuì delle pensioni vitalizie al suo segretario e agli altri suoi collaboratori e fece costruire un asilo pubblico per i bambini poveri in uno dei quartieri di Torino più marginali dell'epoca. Enrico De Nicola, primo presidente della Repubblica Italiana, dispose nel suo testamento un lungo elenco di donazioni a orfanotrofi, asili e ospizi, oltre a destinare una somma al Monte di Pietà di Napoli perché cancellasse i debiti dei più poveri.