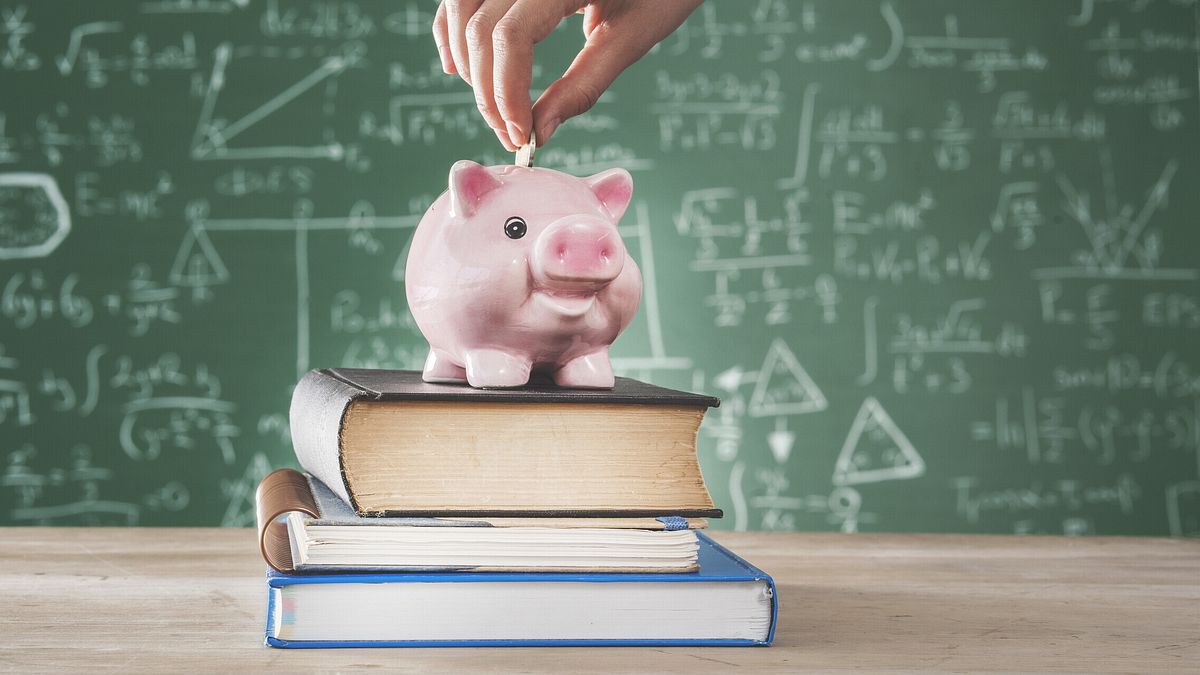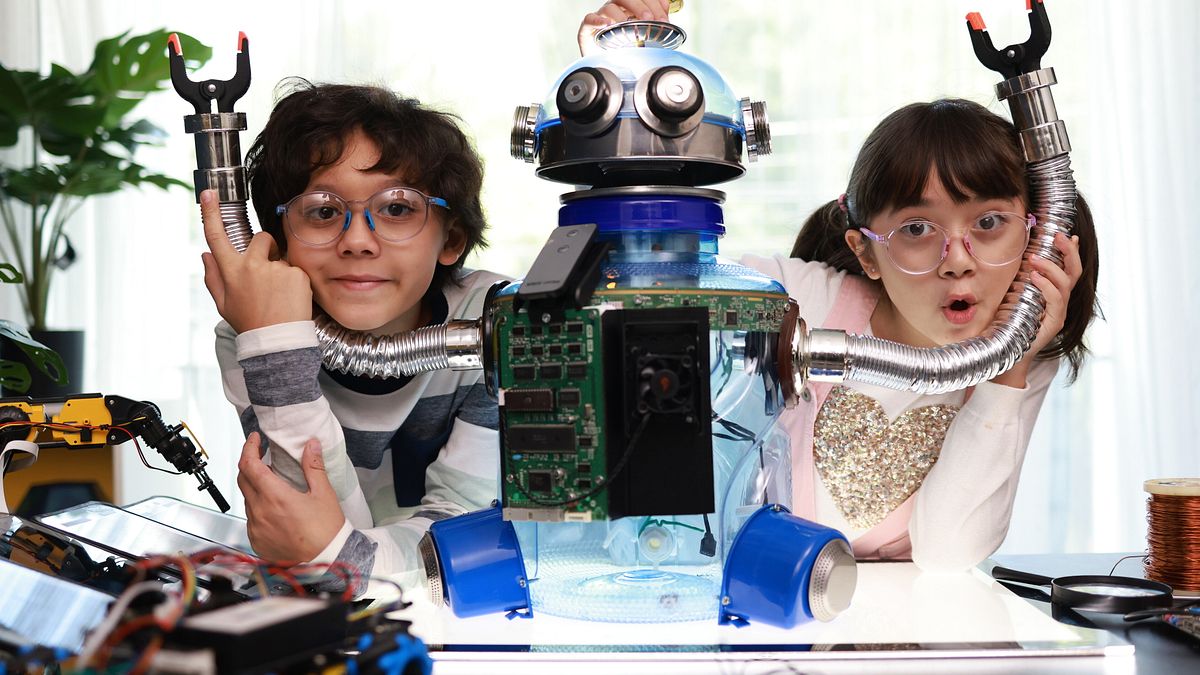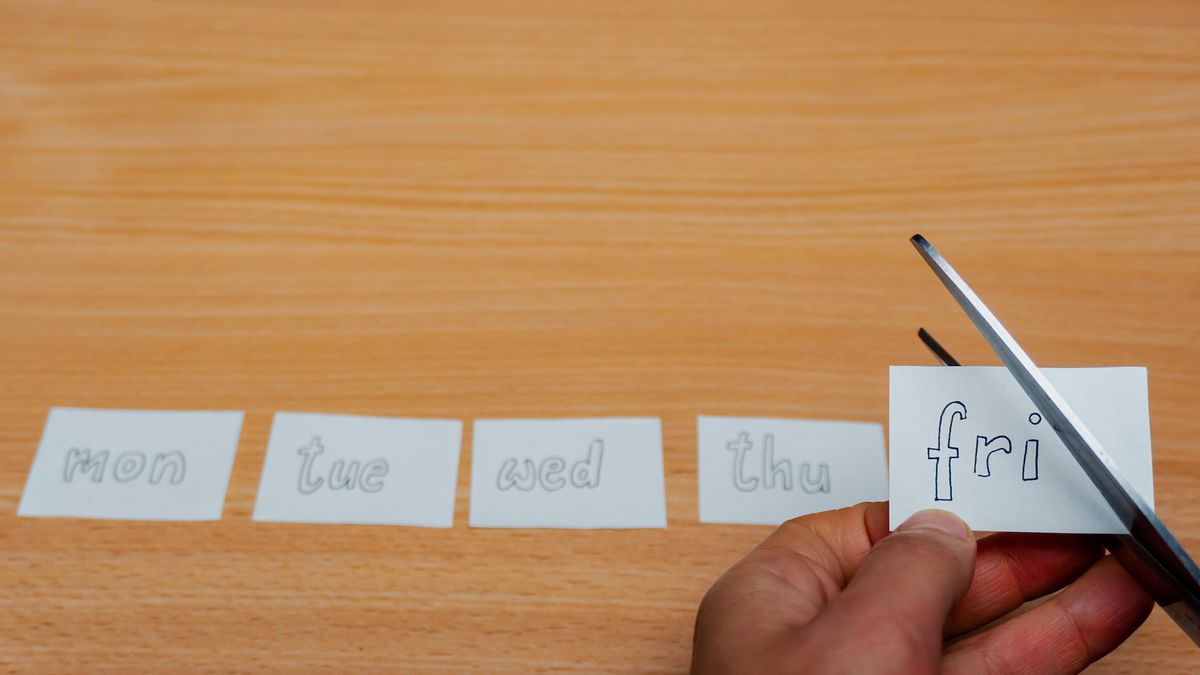Italia seconda in Europa per NEET: ecco perché un milione e mezzo di giovani sono senza lavoro e studio
I dati Eurostat e l'iniziativa di Fondazione Asilo Mariuccia rivelano un Paese in crisi demografica, dove i giovani faticano a entrare nel mondo del lavoro e ritardano le scelte di vita
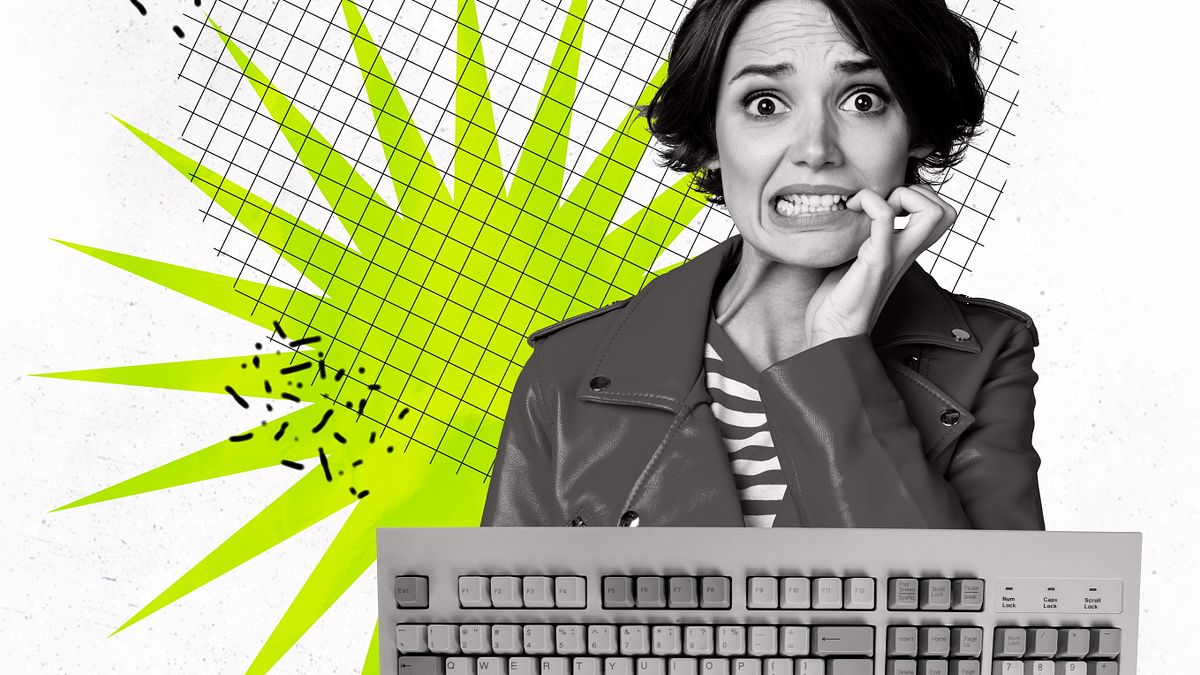
© Istockphoto
L'Italia è un Paese sempre più vecchio e con sempre meno giovani. Ma il dato ancora più preoccupante è che questi pochi giovani fanno fatica a trovare il proprio posto nella società: il nostro Paese ha il secondo tasso più alto di NEET (giovani che non studiano, non lavorano e non sono in formazione) in Europa, superato solo dalla Romania. È quanto emerge dai dati Eurostat, su cui riflette l'iniziativa “Con i giovani, contro la violenza. Prevenire il disagio e difendere le relazioni per una Lombardia Zero NEET” promossa da Fondazione Asilo Mariuccia, in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore e ALTIS Graduate School of Sustainable Management.
I numeri lo evidenziano in modo preoccupante: in Italia ci sono oggi oltre un milione e mezzo di giovani che non studiano, non lavorano e non sono in formazione. L'incidenza di NEET tra i 15 e i 29 anni è del 15,2% della popolazione in quella fascia d'età. Un dato che ci colloca al secondo posto in Europa, dietro solo alla Romania (19,4%) e ben al di sopra della media UE dell'11%.
Le cause del fenomeno NEET
Il fenomeno degli inattivi in Italia affonda le radici in un mix di fattori strutturali. La prima causa è la profonda crisi demografica, con la costante perdita di popolazione giovanile che riduce il potenziale produttivo del Paese. A questo si aggiunge un mercato del lavoro che rappresenta un percorso a ostacoli, come dimostra il forte calo degli occupati nella fascia 25-34 anni. La criticità è aggravata dal problema della bassa qualificazione, con una quota di laureati ben al di sotto della media europea e da un forte divario territoriale e di genere che spinge le fasce più deboli, in particolare le giovani donne del Mezzogiorno, verso l'inattività e l'esclusione sociale.
"La condizione dei NEET rappresenta uno dei segnali più preoccupanti della nostra società. La sua incidenza misura lo spreco di capitale umano delle nuove generazioni. L’Italia, purtroppo, resta tra i Paesi europei con i livelli più alti: un paradosso, considerando che siamo anche tra quelli con meno giovani e con un processo di “degiovanimento” più accentuato. Rafforzare la formazione e il raccordo tra scuola e lavoro è l’investimento decisivo per assicurare vitalità economica, innovazione e sostenibilità sociale" commenta Alessandro Rosina, sociologo e docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Un Paese che invecchia rapidamente
Il quadro demografico italiano è allarmante. Dal 2012 al 2024, la popolazione giovanile tra i 15 e i 34 anni è diminuita di oltre due milioni di unità, passando da 13,4 milioni a 11,3 milioni. Un calo del 15,8% in poco più di un decennio. Si segnala inoltre la perdita di oltre 2,3 milioni di individui nella fascia d'età tra i 25 e i 34 anni in vent'anni (erano oltre 8,6 milioni nel 2004 e oggi sono circa 6,3 milioni), la fascia che più alimenta lavoro e innovazione. In Italia, gli under 15 sono ormai meno della metà degli over 65, e presto saranno meno di uno su tre. C'è una generazione che rischia di diventare la più fragile e numericamente più piccola della storia recente italiana.
Nel contempo, l'età media della popolazione è salita a 46,6 anni nel 2024, con un incremento di 2,5 anni rispetto al 2012. L'indice di vecchiaia è schizzato a 193,0, mentre quello di dipendenza strutturale ha raggiunto il 58,7%, segnando rispettivamente un aumento del 20,0% e del 6,9% rispetto al 2012.
Particolarmente critica la situazione nel Mezzogiorno, dove la popolazione giovanile tra i 15 e i 34 anni è crollata del 21,9% dal 2012 al 2024, perdendo quasi un milione di giovani (da 4,3 a 3,4 milioni). Nel Nord-ovest il calo è stato del 14,7%, nel Nord-est del 13,5% e nel Centro dell'11,0%.
L'ingresso nel mondo del lavoro: un percorso a ostacoli
L'accesso al mercato del lavoro per i giovani italiani è tra i più difficili d'Europa. Nel 2023, solo il 23,1% dei giovani tra i 15 e i 24 anni risultava occupato, il dato più basso dell'Unione Europea insieme alla Grecia (23,0%). La media UE si attesta invece al 35,3%, con punte del 58,4% nei Paesi Bassi e del 52,2% in Germania. In Italia, gli occupati nella fascia 25-34 anni sono scesi da oltre 6 milioni a circa 4,2 milioni, riducendo il loro peso tra i lavoratori dal 27,1% al 17,8%.
Il tasso di disoccupazione giovanile in Italia è del 20,4% per la fascia 15-29 anni, contro una media europea del 13,3%. Particolarmente grave la situazione delle giovani donne del Sud, dove il tasso di disoccupazione raggiunge il 37,1% per le 15-24enni. L'Italia detiene anche il record negativo per il tasso di inattività giovanile: il 27,4% dei giovani tra i 15 e i 29 anni non cerca lavoro né è disponibile a lavorare, più del doppio della media UE (12,7%).
Le differenze di genere e territoriali
Le disuguaglianze di genere si manifestano chiaramente nei dati occupazionali. Tra i 25 e i 29 anni, il tasso di occupazione maschile è del 71,0%, mentre quello femminile si ferma al 54,6%. Il divario è ancora più marcato al Sud, dove lavora solo il 42,0% delle giovani donne, contro il 64,2% degli uomini della stessa età.
Per quanto riguarda i NEET, il fenomeno è prevalentemente femminile: tra i 25 e i 29 anni, sono NEET il 18,7% delle donne contro il 13,5% degli uomini. Nel Mezzogiorno, ben il 30,1% delle giovani donne tra i 25 e i 29 anni non studia, non lavora e non è in formazione. La fotografia territoriale evidenzia un'Italia spaccata in due: nel Nord-ovest il tasso di occupazione giovanile (25-29 anni) è del 72,7%, nel Sud crolla al 51,0%. Per i NEET, il Sud registra un'incidenza del 25,8%, quasi il triplo del Nord-ovest (9,0%). In Lombardia, la quota di NEET è pari all'8,9% nel 2024.
Scelte di vita rimandate
Le difficoltà lavorative si riflettono anche sulle scelte di vita. L'età media alla quale i giovani italiani escono dalla casa dei genitori è di 30,0 anni, ben 4,1 anni oltre la media europea di 25,9 anni. Nel Sud la situazione è ancora più estrema: si esce di casa in media a 31,6 anni.
Anche la formazione di una famiglia viene posticipata: l'età media al matrimonio in Italia è di 36,5 anni per gli uomini e 33,6 anni per le donne, rispettivamente 2,0 e 2,3 anni in più rispetto alla media UE. Di conseguenza, l'età media al primo figlio è salita a 31,7 anni, contro i 29,7 anni della media europea.
Istruzione: un quadro contraddittorio
Sul fronte dell'istruzione emergono luci e ombre. Da un lato, la quota di giovani tra i 18 e i 24 anni che abbandonano precocemente gli studi si è ridotta dal 17,3% del 2012 al 10,5% del 2023, avvicinandosi alla media UE del 9,5%. Dall'altro, permane un grave problema di bassa qualificazione: solo il 30,6% dei giovani italiani tra i 25 e i 34 anni ha una laurea, contro il 42,8% della media europea. Preoccupante anche il dato sulla competenza digitale: il 73,8% dei giovani italiani tra i 16 e i 29 anni possiede competenze digitali almeno di base, un valore inferiore alla media UE del 78,7%. Inoltre, chi possiede un titolo di studio basso tende più spesso a sentirsi in una condizione di peggioramento, e tra le persone con livelli di istruzione più bassi la sensazione di progresso, soprattutto economico, è molto meno diffusa rispetto alla media. Solo il 57% della popolazione si dichiara soddisfatto della propria vita sociale.
Le proposte per invertire la rotta
Di fronte a questo quadro, è tempo di costruire nuove alleanze, tra istituzioni, famiglie, scuola e mondo del lavoro, per contrastare l'aumento dei NEET e per prevenire la violenza che troppo spesso nasce dal disagio e dall’esclusione.
Potenziare l'orientamento scolastico, superando stereotipi di genere e valorizzando l'istruzione tecnica e professionale per ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro.
Introdurre incentivi fiscali per favorire l'uscita dei giovani dalla casa dei genitori, come detrazioni per l'affitto o agevolazioni per l'acquisto della prima casa.
Rafforzare le politiche di sostegno alla genitorialità, con congedi parentali più lunghi e retribuiti, asili nido accessibili e flessibilità lavorativa per conciliare vita familiare e professionale.
Sviluppare percorsi di formazione continua e riqualificazione professionale per i NEET, con particolare attenzione alle competenze digitali e alle esigenze del mercato del lavoro. Attraverso i laboratori di educazione al lavoro di Fondazione Asilo Mariuccia sono stati formati oltre 500 ragazzi. Il nuovo polo educativo di Porto Valtravaglia (Varese) sarà ristrutturato per triplicare la capacità recettiva, con 5 laboratori di educazione al lavoro (florovivaismo, carpenteria navale, ciclomeccanica, cucina, barberia) e un centro diurno, accogliendo fino a 90 giovani.
Promuovere politiche di welfare aziendale che facilitino l'ingresso stabile dei giovani nel mondo del lavoro, superando la precarietà che caratterizza le prime esperienze professionali.
Emanuela Baio, Presidente di Fondazione Asilo Mariuccia, sottolinea: "Restituiamo dignità, fiducia e autonomia lavorativa, partendo da ciò che spesso manca: il rispetto dell’identità di ciascuno. Siamo di fronte a una sfida tanto culturale quanto sociale: dimostrare che nessun ragazzo è irrecuperabile, se trova adulti capaci di crederci davvero”.