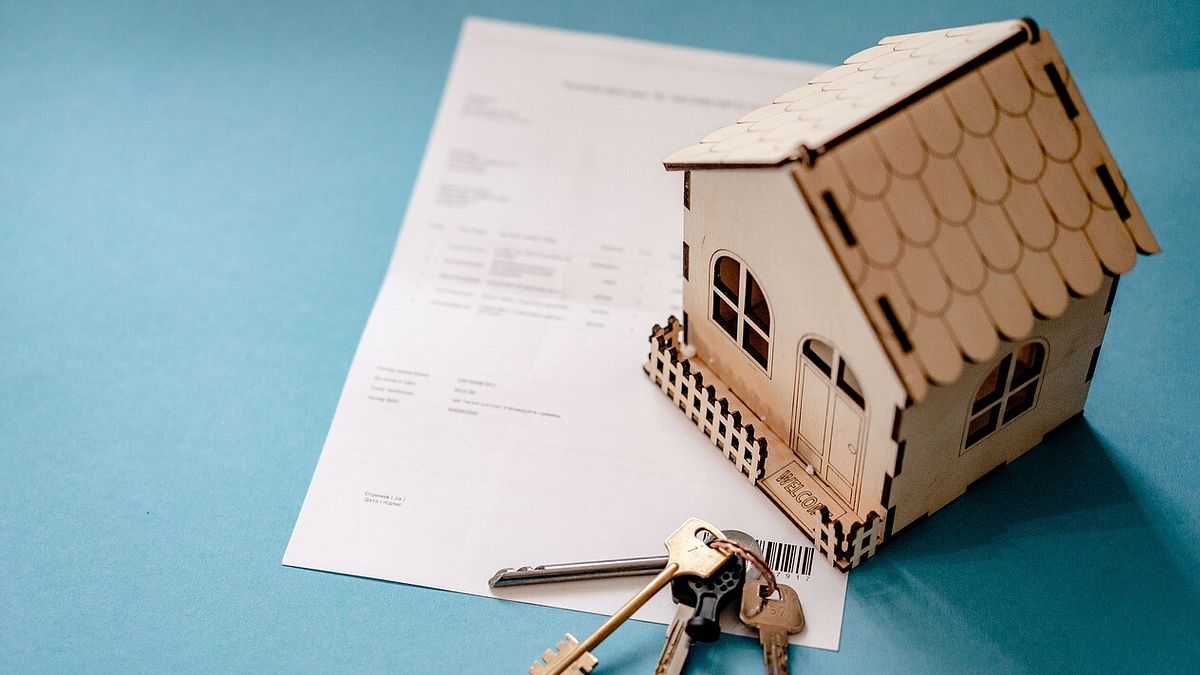Care economy, quanto vale il lavoro di cura e qual è l'impatto per lo Stato
Il settore, responsabile del 4,4% del Pil, produce 84,4 miliardi di euro, più di agricoltura e ristorazione. Ma la diffusa irregolarità, specialmente tra colf e badanti, è un problema che si ripercuote sull'intero sistema

© Istockphoto
Con il costante invecchiamento della popolazione italiana, la care economy (cura e assistenza delle persone) sta diventando sempre più cruciale per il nostro Paese, non solo dal punto di vista strettamente sociale ma anche da quello economico, essendo responsabile del 4,4% del Pil (pari a 84,4 miliardi di euro prodotti). Numeri più alti, per dare l'idea, di ristorazione e agricoltura. Eppure, in questo settore esiste una diffusa irregolarità (mancanza di contratto o, addirittura, assenza di una retribuzione) che impatta sulle condizioni di vita dei lavoratori e sulle casse dello Stato. Il valore economico del lavoro di cura non retribuito è infatti paragonabile a quello di più Manovre finanziarie messe insieme.
Cos'è la care economy
Come riporta l'Organizzazione internazionale del lavoro (agenzia specializzata delle Nazioni Unite), quando si parla di care economy (traducibile in "economia dell'assistenza") ci si riferisce all'insieme di attività economiche legate alla cura e all'assistenza delle persone, tra cui la sanità, i servizi sociali e più in generale l'assistenza a bambini, anziani e persone con disabilità. Si tratta di una consistente "fetta" dell'economia che sta assumendo un'importanza sempre maggiore dato il progressivo invecchiamento della popolazione e la crescente consapevolezza dell'importanza della cura e del benessere. Il lavoro di cura, spiega ancora l'Oil, viene svolto sia nel settore pubblico e privato (micro, piccole e medie imprese) sia nei nuclei familiari. In condizioni normali, il lavoro di cura è regolarmente retribuito. Ma, come denunciano da tempo l'Oil e chi fa parte del settore, spesso non viene retribuito del tutto o comunque in modo non conforme alle normative vigenti.
I settori della care economy
Per poter quantificare il Pil della care economy, serve capire quali sono i settori economici che la compongono. Un aiuto arriva dall'Osservatorio Domina sul lavoro domestico, che nel suo ultimo Rapporto (relativo all'anno 2024 e realizzato con la collaborazione scientifica della Fondazione Leone Moressa) considera quattro settori specifici. Partiamo dal primo: la produzione di prodotti farmaceutici di base e di altri preparati. Ai fini del calcolo, Domina prende in considerazione la parte di produzione "assorbita" dagli over 65, che è pari al 60%, ossia 7 miliardi di euro.
Il secondo settore è l'attività dei servizi sanitari, intese come le attività di ospedali generici o specialistici, visite mediche e trattamenti di medicina generale e specialistica. Anche qui, come nel caso dei farmaci, gli over 65 hanno un maggiore bisogno di cura: secondo i dati Istat, l'incidenza degli over 65 sia nei ricoveri che nei contatti col medico di famiglia è del 49-50%. Tradotto in termini economici, 44 miliardi di euro.
Gli ultimi due settori - entrambi considerati nella loro interezza - sono l'assistenza sociale in strutture residenziali/semiresidenziali (17 miliardi di euro) e il lavoro domestico, quindi colf e badanti (16 miliardi di euro).
Dai calcoli di Domina, la somma di tutti questi settori produce - come anticipato - 84 miliardi di euro, pari al 4,4% del Pil (valore aggiunto di tutti i settori).
Se la care economy fosse un settore unico
Se rappresentasse un settore economico a sé stante inserito nelle voci del Pil, la care economy si posizionerebbe tra il trasporto e il magazzinaggio (89,4 miliardi, pari al 4,7% del Pil) e i servizi di alloggio e ristorazione, ossia alberghi, bar e ristoranti (49,9 miliardi, pari al 4,2% del Pil). Non solo: come emerge dal Rapporto di Domina, supererebbe (e di gran lunga) un settore fondamentale come quello dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, che produce "solo" 39,5 miliardi, ossia il 2,1% del Pil. Si tratta di dati che confermano come la care economy, allo stato attuale, non abbia ancora la visibilità che merita.
Il lavoro domestico
Cerchiamo ora di quantificare l'impatto del lavoro domestico, uno settori chiave della care economy. Secondo l'Osservatorio Domina, il lavoro domestico produce precisamente 15,8 miliardi di valore aggiunto, con un impatto sul Pil dello 0,8%. In alcune realtà territoriali incide in misura ancora maggiore, come in Umbria (1,2%) e in Sardegna (1,2%).
Questo valore, più specificamente, deriva dalla spesa delle famiglie che sono datori di lavoro domestico, che nel 2023 hanno speso 6 miliardi per le retribuzioni, 446 milioni di Tfr e 1,1 miliardi di contributi previdenziali. In totale, le famiglie italiane hanno speso 7,6 miliardi di euro per i lavoratori domestici regolarmente assunti. E per quelli irregolari?
Irregolarità dilagante
L'Osservatorio Domina spiega che, negli ultimi anni, diverse iniziative di informazione e sensibilizzazione sono state condotte in merito dalle istituzioni e dalle parti sociali, che hanno portato a una diminuzione del tasso di irregolarità nel lavoro domestico (spesso dovuta all'assenza di un contratto o alla mancanza del permesso di soggiorno del lavoratore).
Un miglioramento che però non basta, visto che storicamente il tasso di irregolarità rimane molto elevato. Ma a quanto ammonta? Secondo i dati Istat, revisionati a settembre 2024, nel 2022 il tasso di irregolarità medio in Italia si attesta al 9,7%, una percentuale che sale al 47,1% nel caso del lavoro domestico. Per dare l'idea della dimensione del fenomeno, basti pensare che l'agricoltura presenta un tasso di irregolarità minore, pari al 20,2%. Nettamente sotto la media la manifattura (4,8%), dove la dimensione delle imprese, i luoghi e l'organizzazione del lavoro rendono più difficile l'irregolarità.
Come scrivono Domina e Fondazione Leone Moressa, applicando il tasso di irregolarità del 2022 ai dati Inps del 2023 su lavoratori e datori di lavoro domestico, è possibile stimare la componente irregolare e, di conseguenza, il numero complessivo di persone coinvolte nel lavoro domestico. Tra lavoratori e datori di lavoro, il settore conta 1,7 milioni di persone censite dall'ente previdenziale. Applicando il tasso di irregolarità, il numero di persone coinvolte supera i 3,3 milioni.
Perché c'è tanta irregolarità
Come spiegato nel Rapporto, la prima causa è la peculiarità del settore: il datore di lavoro spesso non è un imprenditore che ha come obbiettivo il profitto, ma un privato che cerca il soddisfacimento di un bisogno essenziale e immediato (come accudire i figli, gli anziani non autosufficienti o prendersi cura della casa). Non essendo un imprenditore, spesso non ha nemmeno dimestichezza con gli obblighi di legge e gli adempimenti burocratici. Domina sottolinea poi la particolare vulnerabilità dei lavoratori domestici, generalmente donne immigrate, che sono più esposti al rischio di povertà e di perdita del lavoro.
Negli ultimi decenni, viene inoltre evidenziato, il settore ha subìto più di altri un trattamento di sfavore: a livello internazionale solo la Convenzione Oil 189/2011 ha riconosciuto la piena dignità del settore. E sebbene in Italia ci sia una tutela molto più alta rispetto ad altri Paesi (anche grazie al ruolo attivo delle parti sociali e al Contratto collettivo nazionale), alcuni aspetti normativi rispecchiano quel retaggio.
L'impatto sulle casse dello Stato
Le ripercussioni sono pesanti non solo per gli stessi lavoratori irregolari, ma anche per l'intero sistema economico, visto il mancato gettito fiscale e contributivo. Su questo aspetto, Domina e Fondazione Leone Moressa hanno analizzato le retribuzioni annuali fornite dall'Inps e ipotizzato che la componente irregolare abbia un andamento simile a quella regolare. Il risultato? Se con i "regolari" si registrano entrate fiscali per 1,2 miliardi euro tra contributi assistenziali/previdenziali, stima Irpef e addizionali locali, aggiungendo gli irregolari le casse dello Stato si riempirebbero, complessivamente, di 2,4 miliardi di euro.
I benefici economici
Oggi le famiglie spendono 7,6 miliardi di euro per i lavoratori domestici regolari, cui si aggiungono 5,4 miliardi per la componente irregolare. Si tratta quindi di una spesa complessiva di 13 miliardi, che porta allo Stato un risparmio di circa 6 miliardi (0,3% del Pil), che sarebbe l'importo di cui lo Stato dovrebbe farsi carico se gli anziani accuditi in casa venissero ricoverati nelle strutture. Per la prima volta, nel Rapporto Domina è stato anche valutato l'impatto di questa spesa sulla produzione italiana: i 13 miliardi investiti dalle famiglie per i lavoratori domestici vengono rimessi in circolo sul mercato, determinando uno stimolo alla produzione. Gli effetti possono essere quantificati in 253,8 milioni di nuove ore di lavoro e 21,9 miliardi di euro di valore della produzione generata.
L'identikit del lavoratore domestico
Come sottolineato dall'Inps, nel 2024 i lavoratori domestici con almeno un contributo versato all'ente previdenziale sono stati 817.403, in diminuzione per il terzo anno consecutivo (-3% rispetto al 2023). Nel 2024 la quota delle badanti è stata del 50,5% sul totale dei lavoratori domestici, superando per la prima volta la quota delle colf (49,5%). È un dato interessante, dovuto all'invecchiamento della popolazione italiana.
Inoltre, secondo Domina, il settore (al 2023) è caratterizzato da una forte presenza femminile (88,6% del totale) e straniera (69% del totale). Tanti, poi, i lavoratori provenienti dall'Est Europa (35,7% del totale), seguiti da quelli italiani (31,1%). Anche la componente proveniente dall'Asia è consistente (16,8%), mentre rimangono minoritarie quelle dell'America Latina (10,2%) e dell'Africa (5,9%), specie di area mediterranea. Infine, sono in crescita i lavoratori provenienti da Georgia, Perù, El Salvador, mentre sono in calo sono quelli da Romania, Moldavia e Bangladesh.
Le possibili soluzioni
Come cercare di arginare il fenomeno dell'irregolarità nel lavoro domestico? Visto che la gran parte degli addetti al settore è costituita da immigrati, una delle proposte in campo è l'introduzione del permesso di soggiorno temporaneo per la ricerca di occupazione, che vale 12 mesi e che faciliterebbe l'incontro tra datori di lavoro italiani e figure professionali di Paesi extraeuropei.
Altra idea è quella di reintrodurre il sistema dello sponsor (sistema a chiamata diretta), originariamente previsto dalla legge Turco-Napolitano del 1998 e poi abolito dalla Bossi-Fini del 2002. E c'è chi auspica una via più radicale, ossia il superamento del meccanismo del decreto Flussi, che prevede quote annuali per l'ingresso di lavoratori non comunitari: l'anno scorso le domande di ingresso (click day del 21 marzo 2024) sono state oltre 112.000, a fronte di soli 9.500 ingressi consentiti. Molti analisti sostengono infatti che il decreto Flussi funzioni più come una "emersione" per lavoratori che sono già presenti sul territorio nazionale. Infine, come scrive il Corriere della Sera, Lorenzo Gasparrini, segretario generale di Domina, ha proposto un "sistema di cashback per le famiglie virtuose che hanno assunto per un lungo periodo un lavoratore domestico", che prevede "una restituzione di una percentuale dello stipendio del dipendente da reinvestire sempre nello stesso settore".