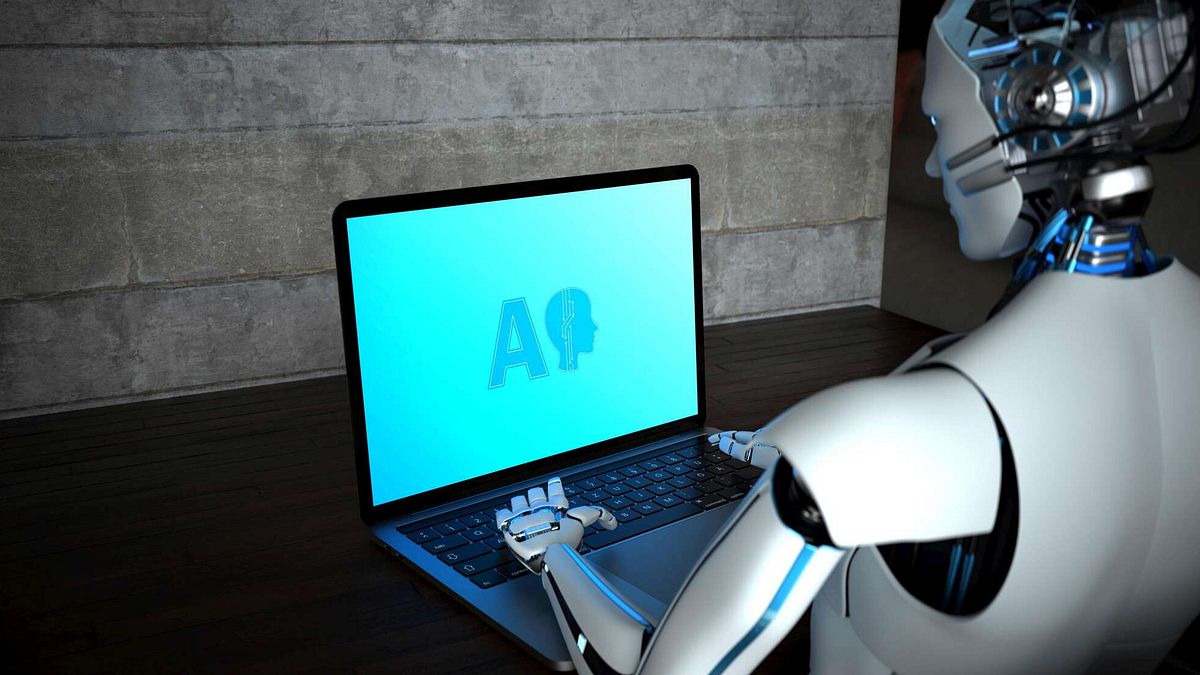Non è un Paese per giovani ma bisogna cambiare, ora lo dice anche la scienza
Dalla povertà crescente alle difficoltà nel trovare lavoro, fino ad arrivare a una salute mentale sempre più precaria. Essere giovani in Italia è complicato, quasi quanto farsi capire dalle altre generazioni. Lo dicono (anche) i ricercatori di OpenPolis
di Manuel Santangelo
© Istockphoto
Non c'è solo la retorica del "non è un paese per giovani" a dirci che forse sarebbe stato meglio formarsi a metà anni Novanta ma anche la scienza, a maggior ragione se si vive in Italia. Almeno stando agli ultimi dati di OpenPolis che hanno provato a capire come stanno i giovani italiani.
A leggerli viene in mente un film attorno a cui si creò un piccolo cult proprio a fine millennio e che fu titolato da noi in modo molto diverso rispetto all'originale: Reality Bites ("la realtà morde") venne infatti stemperato in Italia nel più sobrio Giovani, carini e disoccupati, consci forse che le vicissitudini di questi ragazzi sul punto di trasformarsi in adulti fatti e finiti non fossero poi così complicate viste da qui. A riesaminare oggi la pellicola, che è invecchiata molto bene da tanti punti di vista, si resta tuttavia colpiti proprio da quanto un ventenne/trentenne di oggi pagherebbe per avere un'esistenza simile a quella dei protagonisti, al netto dei problemi che questi ultimi devono comunque risolvere per far andare avanti la trama. Colpa di una situazione complessa propria del nostro Paese e ben fotografata ormai anche dai dati e dagli studi scientifici.
Una macchina che va solo in folle
I ricercatori di OpenPolis hanno provato a capire come stanno i giovani italiani, analizzando i dati della ricerca Lancet Commission on Adolescent Health and Wellbeing, pubblicata sulla rivista The Lancet. Lo studio ricostruiva la condizione di giovani e adolescenti a livello mondiale dall'inizio della pandemia a oggi, evidenziando i rischi per il loro benessere da qui al 2030. Limitandosi tuttavia ai nostri connazionali OpenPolis ha fotografato un quadro sconfortante e, va detto, non troppo sorprendente. È infatti palese come si sia inceppato col tempo qualcosa nel movimento intergenerazionale. Appare facile riscontrare come si siano piano piano impolverati gli ingranaggi di una macchina che a lungo pareva procedere senza affanni ma ora, piuttosto che cercare di capire chi abbia rallentato la corsa, va compreso come poter riuscire ad aggiustare il cambio di una macchina che al momento procede per inerzia, di fatto solo in folle.
La parte che sorprende di più dello studio da cui siamo partiti è quello che riguarda la salute. Non solo perché forse nel nostro Paese più che in altri "finché c'è la salute" è stato per anni il mantra dietro cui ridimensionare qualunque difficoltà. In un modo estremamente liquido e senza certezze anche le nuove generazioni si appellavano alla fine a quella certezza quasi incrollabile: si sarebbe vissuti più a lungo e generalmente rischiando meno in termini di malattie rispetto a chi ci ha preceduto. Una sicurezza che starebbe però diventando sempre meno granitica, gravata da un crescente carico di morbilità (la frequenza di contrarre malattie) e mortalità, dovuto a un rapido aumento di malattie non trasmissibili e disturbi mentali.
A tutto questo vanno aggiunte anche le variabili esogene, che sembrerebbero rendere accidentata quella strada che doveva protrarci inevitabilmente verso una vita più lunga e serena: gli effetti dei conflitti, degli sfollamenti, della rapida urbanizzazione, delle pandemie attuali e future, del cambiamento climatico e del degrado ambientale. Sono tutti fattori che vanno a creare ulteriori ansie e che quindi portano a sempre più problemi legati alla salute mentale.
Le paure, i disturbi mentali e le ansie anche ecologiche
Secondo Lancet in futuro ben 42 milioni di anni di vita in salute potrebbero essere persi a causa di disturbi mentali o suicidio (2 milioni in più rispetto al 2015). Una stima globale che spaventa anche se ci si limita a valutare i numeri nel nostro Paese.
Nell’ottobre scorso, Istat ha stimato che quasi il 14% dei minori si sia trovato in povertà assoluta nel 2023, l’incidenza più elevata dal 2014, mentre il nostro Paese resta ai vertici europei per giovani tra 15 e 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono in formazione (i cosiddetti Neet). Si stanno insomma creando i presupposti per almeno due generazioni destinate a cadere nell'apatia assoluta, un'abulia che può farsi cronica e che comunque non può essere spiegata solo con la difficoltà nel trovare lavoro.
Negli ultimi anni si parla per esempio sempre più spesso di "eco-ansia" anche alle nostre latitudini. Uno studio realizzato dall’Italian Institute for Planetary Health (IIPH) dimostrava, già nel 2022, come le ondate di calore estremo, gli incendi e la crisi idrica producessero effetti drammatici sul benessere mentale delle persone. Non è un caso che, proprio in risposta a un tale disagio, si sia iniziato a rispondere con un ritorno dell'attivismo collettivo su certi temi: la quota di 18-19enni che hanno preso parte ad associazioni ecologiche, per i diritti civili e per la pace è stata pari al 3,3% nel 2024 (era lo 2,4% nel 2023). Un dato molto superiore rispetto a quello del resto della popolazione (1,6%).
Vanno poi, a costo di sembrare banali, ricordati gli effetti sul cervello umano dell’abuso delle piattaforme social, con l'emergere di fenomeni negativi a esse correlati soprattutto tra i più giovani: si è ormai iniziato a famigliarizzare in questo senso con inglesismi come "hate speech" o "fomo" (la paura di essere tagliati fuori), che possono essere amplificati dall'eccessiva esposizione al mondo virtuale. A riprova di questo giova ricordare anche studi come il report The Mental State of the World di Sapien Lab del 2021. Condotto in 34 nazioni, quest'ultimo mostra come la crescita dell’uso di smartphone e social media e l’aumento dell’isolamento siano tutti aspetti legati a un calo nella salute mentale collettiva, soprattutto nei giovani adulti di età compresa tra 18 e 24 anni.
Un disagio spiegato con ironia in "riserve indiane"
C'è insomma una ansia diffusa, che stride quasi con una certa logica, in base alla quale si sarebbe portati a pensare che i pochi giovani italiani dovrebbero provare una certa soddisfazione nel dover dividere la torta delle opportunità con sempre meno coetanei. Va tuttavia ricordato che non stiamo parlando di un gioco a somma zero e che quindi tutto tende a conformarsi al volere di una maggioranza (quella degli over sessanta) decisamente più rumorosa. Ai giovani, per comunicare il proprio malessere, resta uno spazio ben delimitato sui social, dove si finisce per esprimere il disagio con modalità non sempre così comprensibili da chi li guarda da fuori. Ecco quindi che, quello che ci dicono i numeri (il 50,3% delle persone tra i 18 e i 34 anni che vive in una condizione socio-economica peggiore rispetto a quella vissuta dai genitori alla loro età), viene esplicitato anche in trend su TikTok apparentemente innocenti.
Secondo uno studio condotto da Demopolis nel 2018, il 66% dei giovani immaginava un domani peggiore rispetto al presente, mentre solo il 9% pensava che sarebbe stato migliore. Una sfiducia confermata da quello che vediamo, distrattamente, ancora oggi tra un reel e l'altro. Un grido d'aiuto seppellito sotto un'ironia assurta a modalità di linguaggio ma che nasconde la paura atavica di sentirsi bloccati. L'anno scorso per esempio tra i Millenial era virale riprendersi mentre si pronunciavano le parole di Edward Cullen in Twilight (vera icona più o meno volontaria di quella generazione). Nel film, quando chiedevano al sopracitato vampiro quanti anni avesse, lui rispondeva "diciassette". Seguiva poi questo scambio: "Da quanto tempo hai diciassette anni?" "Da un po’". Il dialogo, estrapolato e trasformato in un audio perfetto per brevi contenuti, diventava quindi un riassunto abbastanza esplicito della condizione di un'intera generazione, intrappolata giocoforza in un'adolescenza infinita. Il tutto mentre i tentativi di decodificare queste persone da parte di chi è più grande spesso si limita a rari meritevoli tentativi, come la newsletter "zio" (che si propone "di capire cosa fanno i teenager di oggi quando fissano i loro telefoni"), senza tuttavia trasformarsi mai in sforzo collettivo. Almeno fino ad oggi.