La musica classica è diventata in Iran uno strumento di protesta: ecco come
Tra aperture e chiusure, il rapporto tra Teheran e la musica "colta" è sempre stato complesso. Tanto che oggi ha finito per raccontare bene un Paese troppo spesso tendente ad arrovellarsi su se stesso
di Manuel Santangelo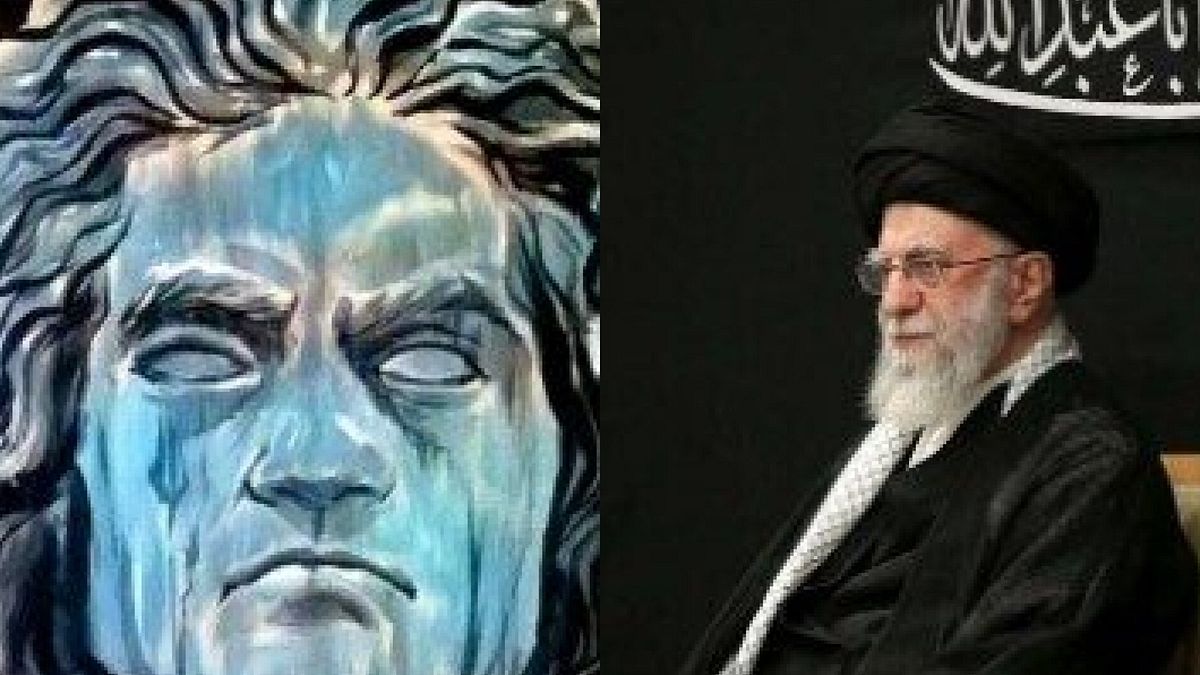
© Tgcom24
Dopo la rivoluzione del 1979, gli iraniani erano confusi: la musica era stata sempre orgogliosamente parte del patrimonio artistico nazionale e sembrava impossibile che fosse stata vietata. Lo shock era forte: si era passato dal cosiddetto qarbzadegi (una vera e propria intossicazione della cultura iraniana, forzatamente influenzata dall'Occidente) a guardare con sospetto qualunque nota venisse suonata, a maggior ragione se la si emetteva fuori dai confini di Teheran.
Un elegante strumento di protesta
Poi, nel settembre del 1980, iniziò la guerra tra Iran e Iraq. Anche i guardiani della rivoluzione khomeinista capirono che la musica poteva tornare a quel punto utile, per migliorare il morale del popolo e per la stretta propaganda. Venne quindi riammessa la musica tradizionale e quella religiosa, con buona pace di tutti quei musicisti che si trovarono in mezzo al guado: chiedendosi se quello che suonavano fosse lecito o illecito. Soprattutto la classica fece porre degli interrogativi, anche perché negli anni nemmeno i capi della neonata Repubblica islamica sembravano avere bene in mente come comportarsi con questa tipologia di musica, che non aveva testi censurabili ma affondava saldamente le sue radici nell'odiato Occidente. Così, tra un tira e molla e l'altro, la musica classica ha cercato la sua strada, diventando un elegante strumento di protesta, perennemente a rischio censura.
Un passato fatto di aperture e chiusure nette
A causa delle sanzioni che alcuni Paesi europei imponevano all’Iran, per un lungo periodo di tempo gli artisti non poterono nemmeno ottenere gli strumenti musicali più alla moda: grandi nomi tornavano in patria e portavano con loro questa nuova musica affascinante e misteriosa, che finiva per essere proposta in maniera clandestina, ibridandola con le espressioni più tradizionali. In Italia passò Mohammad-Reza Lofti, che dopo essere scappato dall’Iran si trovò a Firenze nella metà degli anni Ottanta, dove si dice provasse a provare italiano usando le parole lette sugli spartiti: "andante", "allegretto" eccetera.
Erano gli anni in cui si provava a dare dalle parti di Teheran nuova linfa, tramite i canali ufficiali, al rilancio di esperimenti come la Tazieh, ossia la forma d’arte tradizionale iraniana più vicina all’opera lirica occidentale (anche se legata a eventi religiosi). Il tutto mentre il placido Bach (uno degli uomini dalla vita più piacevolmente noiosa che si potesse immaginare) risultava agli occhi di una generazione proibito e rivoluzionario al pari del punk ad altre latitudini. Oggi le cose non sono così diverse: in una qualsiasi sera di primavera il pubblico accorso alla Vahdat Hall della capitale sanno che le note di Beethoven potrebbero venire abortite da un momento all'altro da una mail del ministero. Sono lontani i tempi dello Scià Nasser Al-Din, che nella seconda metà dell'Ottocento portò in Iran l'opera occidentale, commissionando ad artisti come il francese Jean Baptiste Lemaire addirittura un inno: si trattava di "Giovane Iran", cantato persino dal noto cantante classico Nazeri.
Agli Scià piaceva la classica
Lo Scià Nasser Al-Din, fu anche il responsabile della costruzione del Teatro dell’Opera, vicino al Palazzo di Golestan, un edificio magniloquente che mirava a essere all'altezza degli omologhi che il sovrano aveva visto nei suoi viaggi, a Vienna o a Parigi. Di quel progetto non ne è rimasto nulla oggi, come hanno avuto vita difficile tante altre istituzioni create nel periodo di un altro scia: il già citato Palhavi. Fu quest'ultimo, in piena ubriacatura occidentalista, a far nascere l’Orchestra Sinfonica di Teheran (1933), la Tehran Opera Company (1957) e la National Ballet Company (1958). Costruì anche un nuovo grande teatro per l'opera che prendeva sempre a riferimento l’Opera di Stato di Vienna. Lo chiamò Roudaki Hall ma oggi tutti lo conoscono con un nome che abbiamo già incontrato: Vahdat Hall.
Fragili aperture
Tutto ciò che ruota attorno alla classica ancora oggi gira attorno a questo teatro, di fatto sotto il controllo del governo. È su quel palco che, nel marzo 2014, si consumò la grande illusione: per la prima volta dai tempi della rivoluzione una cantante si esibì in pubblico, in un nuovo allestimento di Gianni Schicchi di Puccini con il Teheran Opera Ensemble, diretto erede della Teheran Opera Company. Erano i primi anni dopo l'elezione di Hassan Rouhani, che nel 2013 sembrava poter essere fautore di un'apertura sostanziale, poi rivelatasi abbastanza fragile. In quest'ottica, qualche mese prima, si era già iniziato pure il processo di rilancio della Orchestra Sinfonica di Teheran sotto la direzione artistica di Ali Rahbari. Fu una stagione breve ma intensa, con la censura che tornò tuttavia presto a farsi sentire sul collo degli artisti. Nel novembre 2015 proprio lo stesso Rahbari si sfogherà dopo l'ennesima censura: "Ho detto che ci esibiremo tutti insieme o lasceremo la sala. Finché sarò il direttore di quest’orchestra, non permetterò questo tipo di trattamento". Cambia in fretta l'aria che si respira a Teheran e basta poco perché il regime si spaventi, ossessionato com'è dal controllo. Inizia a quel punto il periodo dei concerti che possono essere rimandati a data da destinarsi anche a pochi minuti dall'inizio. Eppure il pubblico nonostante le difficoltà logistiche non manca mai, foraggiato anche da un mercato nero dove sottobanco si trova più o meno tutto e che aiuta ad appassionarsi.
Un pubblico giovane e affamato di classica
Differentemente da altri posti nel mondo, in Iran la musica classica non è mai diventata un reperto da studiare a scuola: per il semplice fatto che è stata assimilata naturalmente come qualsiasi altro tipo di musica, trasformandosi persino col tempo in strumento di protesta. Pensateci bene: quale musica migliore di quella classica, in cui non c'è un testo chiaro e cadenzato pronto a esplicitare qualunque sottotesto ma in cui il messaggio viene veicolato invece attraverso le note, per aprire gli orizzonti culturali all'interno un sistema illiberale e suoi dogmi?
Il volume si alza
Si pensi in questo senso al Fajr International Music Festival, cui nel 2017 ha partecipato la Fondazione del Festival Pucciniano accanto all’Orchestra Sinfonica di Tehran. Nello stesso anno un altro monumento della nostra musica colta, Riccardo Muti, diresse un concerto con musicisti iraniani e italiani al National Garden di Teheran, nell'ambito del progetto “Road of Friendship”. Ma si tratta spesso di doppi standard, con alcuni artisti che vengono invece respinti spesso pretenziosamente, in una roulette russa dove tutto soffre dell'umoralità di un potere imperscrutabile e poco capibile, soprattutto per chi prova a comprenderne le dinamiche di ragionamento dall'esterno. Intanto il volume della musica sale, sale sempre più alto, nelle strade di Teheran, Tabriz e Isfahan, nella speranza che il crescendo rossiniano non lasci più indifferente nessuno. Dopo il successo di Leggere Lolita a Teheran forse è venuto il momento di scrivere le pagine di una nuova storia: "suonare Mozart a Tabriz", per uscire dallo spartito una volta di più.




