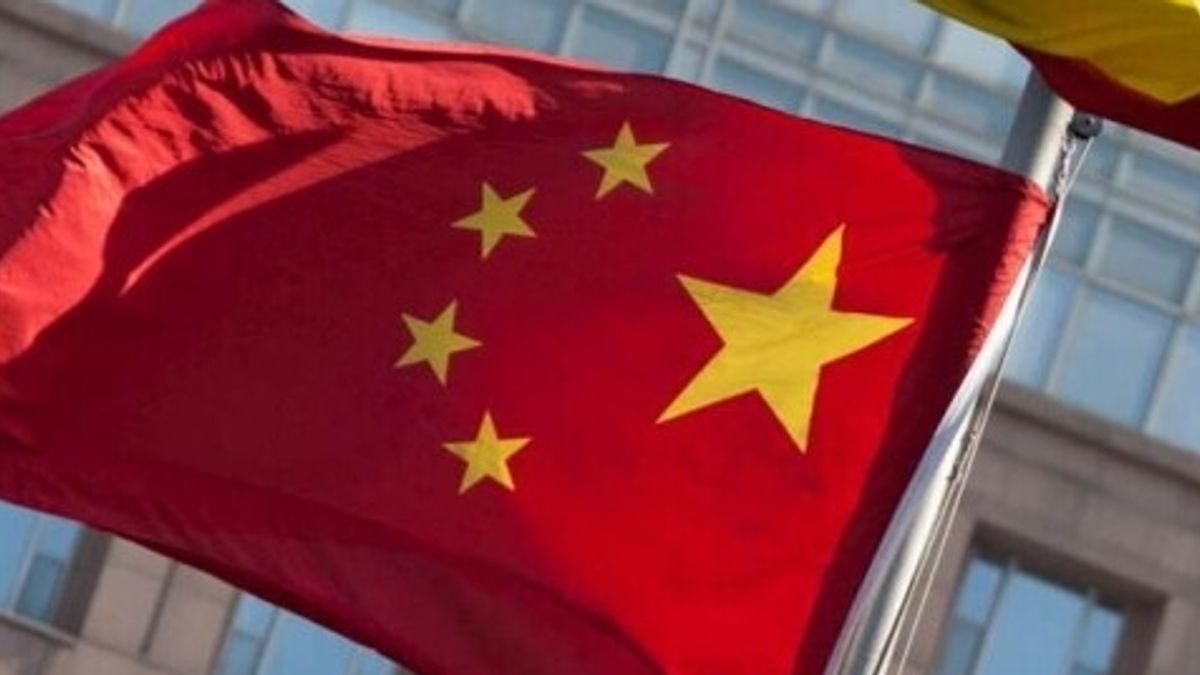La Cina cambia rotta: da un figlio obbligatorio ai sussidi per ogni neonato, ma i soldi non bastano
Il governo introduce il primo assegno nazionale per i bimbi sotto i tre anni, ma analisti avvertono che gli incentivi restano insufficienti di fronte a crisi sociale, costi elevati e problemi strutturali

© IPA
Dalla politica del figlio unico alla spinta verso una natalità sostenuta dallo Stato. La Cina, nel tentativo di invertire un drammatico declino demografico, ha annunciato per la prima volta un sussidio nazionale per i bambini sotto i tre anni. Il governo cinese verserà 3.600 yuan all'anno (circa 460 euro) per ogni figlio nato dopo il 1° gennaio 2025. Una svolta simbolica rispetto al rigido controllo delle nascite che, per decenni, ha limitato le famiglie a un solo bambino. Ma economisti e sociologi avvertono: gli incentivi economici, seppur benvenuti, rischiano di essere un palliativo di fronte a problemi ben più profondi. L'elevato costo della vita, le incertezze lavorative e un cambiamento radicale della struttura sociale stanno scoraggiando le nuove generazioni dal formare famiglie numerose. E così, mentre la popolazione invecchia e il tasso di fertilità tocca minimi storici, Pechino si trova costretta a ripensare completamente il proprio modello demografico.
Dalla politica del figlio unico al sostegno di Stato
Per oltre trent'anni, la Cina ha imposto una delle politiche demografiche più restrittive al mondo: il figlio unico. Introdotta nel 1980 per frenare la crescita della popolazione, la misura ha avuto effetti collaterali profondi e duraturi, fra cui un forte squilibrio di genere e un progressivo invecchiamento della popolazione. Dal 2015, Pechino ha iniziato ad allentare i vincoli, prima autorizzando due figli, poi tre, ma con scarso successo. Il passaggio a politiche di incentivo, come l'attuale sussidio, rappresenta una svolta simbolica. Tuttavia, la memoria collettiva di decenni di repressione resta viva e condiziona la percezione dei cittadini rispetto alla genitorialità.
La misura: 3.600 yuan all'anno per ogni bimbo fino a 3 anni
Il nuovo provvedimento, annunciato dal Ministero delle Finanze cinese e in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2025, prevede un rimborso fiscale annuale di 3.600 yuan per ogni figlio sotto i tre anni. Si tratta del primo incentivo su scala nazionale destinato direttamente alle famiglie per sostenere i costi della prima infanzia. Oltre al bonus, alcune autorità locali hanno introdotto misure complementari: esenzioni fiscali, asili gratuiti o a prezzo ridotto, bonus una tantum per le nascite. L'obiettivo, esplicitamente dichiarato, è duplice: contrastare il calo delle nascite e stimolare la spesa familiare, in un contesto di rallentamento economico interno.
Perché i sussidi non bastano: il costo reale di crescere un figlio
Secondo le stime riportate da fonti internazionali, il costo medio per crescere un figlio in Cina urbana fino ai 18 anni può superare 300.000 yuan (oltre 38.000 euro). Un dato che spiega perché sempre più coppie, soprattutto nei centri urbani, scelgano di non avere figli o di fermarsi a uno solo. L'entità del bonus, seppur significativa per alcune fasce di reddito, è considerata troppo bassa per incidere realmente. Inoltre, la precarietà lavorativa e la mancanza di supporti strutturali, come congedi parentali estesi o reti di welfare stabili, continuano a pesare sulle scelte riproduttive.
Radici sociali e culturali del declino demografico
Oltre ai fattori economici, il calo delle nascite in Cina è legato a cambiamenti culturali profondi. L'emancipazione femminile, l'urbanizzazione e l'aumento del livello di istruzione hanno ridefinito le priorità delle nuove generazioni. Sempre più donne preferiscono concentrarsi sulla carriera o rimandano la maternità, spesso oltre l'età considerata "fertile" dalla società cinese. In parallelo, l'aumento dei divorzi, il costo elevato del matrimonio e la crescente pressione sociale su genitori e figli hanno reso la genitorialità una scelta sempre più gravosa.
Verso modelli più ampi: cosa dicono gli esperti e i casi locali
Esperti cinesi ed esteri concordano nel ritenere che una strategia efficace debba andare oltre gli incentivi economici. Servono riforme strutturali in grado di costruire un ambiente favorevole alla famiglia: politiche per la casa, asili accessibili, orari di lavoro flessibili, parità di genere. Alcune città, come Hangzhou e Shenzhen, hanno già avviato sperimentazioni in questa direzione, con risultati incoraggianti ma ancora lontani dalla scala necessaria. Il rischio, secondo diversi analisti, è che la Cina segua lo stesso percorso di Giappone e Corea del Sud, dove i tassi di natalità si sono stabilizzati su livelli bassissimi nonostante decenni di politiche pro-nascita.
Perché le politiche di stimolo non hanno funzionato sinora
Gli esperti ritengono che l'approccio della Cina alla crisi demografica sia stato troppo graduale e frammentato. Le prime misure, come la possibilità di avere più figli, non sono state accompagnate da politiche di welfare sufficientemente solide. Il mercato immobiliare, in particolare, rappresenta un ostacolo: i prezzi delle case in molte città sono proibitivi per le giovani coppie. Inoltre, la mancanza di servizi per l'infanzia accessibili e l'insufficienza del congedo parentale maschile hanno reso difficile per le famiglie considerare l'arrivo di un secondo o terzo figlio. Anche i sussidi introdotti, come il bonus di 3.600 yuan, sono considerati troppo esigui rispetto ai costi complessivi di crescita di un figlio.
Il ruolo dell'urbanizzazione nella crisi demografica
Il rapido processo di urbanizzazione in Cina ha trasformato profondamente la struttura della famiglia. Nei grandi centri urbani, la vita è più cara, lo spazio abitativo ridotto e le dinamiche lavorative molto competitive. Questi fattori hanno scoraggiato la natalità, soprattutto tra le donne, sempre più presenti nel mercato del lavoro e con livelli di istruzione più elevati. In campagna, dove i figli rappresentavano una risorsa economica, il fenomeno è meno marcato, ma il trasferimento verso le città ha fatto sì che anche lì il tasso di fertilità si abbassasse. La conseguenza è un calo delle nascite che interessa in modo omogeneo tutto il Paese, sebbene con intensità variabili.
Confronto internazionale: cosa hanno fatto Giappone e Corea del Sud
Giappone e Corea del Sud offrono esempi utili per comprendere l'efficacia (e i limiti) delle politiche di incentivazione alla natalità. In Giappone, nonostante misure che includono bonus, congedi parentali e sostegno all'infanzia, il tasso di fertilità resta tra i più bassi al mondo. In Corea del Sud, il governo ha investito miliardi di dollari in sussidi, ma senza successo: nel 2023, il tasso di fertilità era sceso a 0,72 figli per donna. Gli analisti osservano che, in entrambi i casi, gli ostacoli culturali e strutturali—come il costo dell'abitazione, il carico sulle madri e la precarietà lavorativa—hanno avuto un peso maggiore degli incentivi monetari. Una lezione che la Cina sembra iniziare a comprendere, ma che richiede un cambio di paradigma più profondo.