IA per le terapie anti cancro, studio danese potrebbe accelerare le cure
Un team danese ha messo a punto una piattaforma che, in poche settimane, progetta molecole per guidare il sistema immunitario contro cellule tumorali
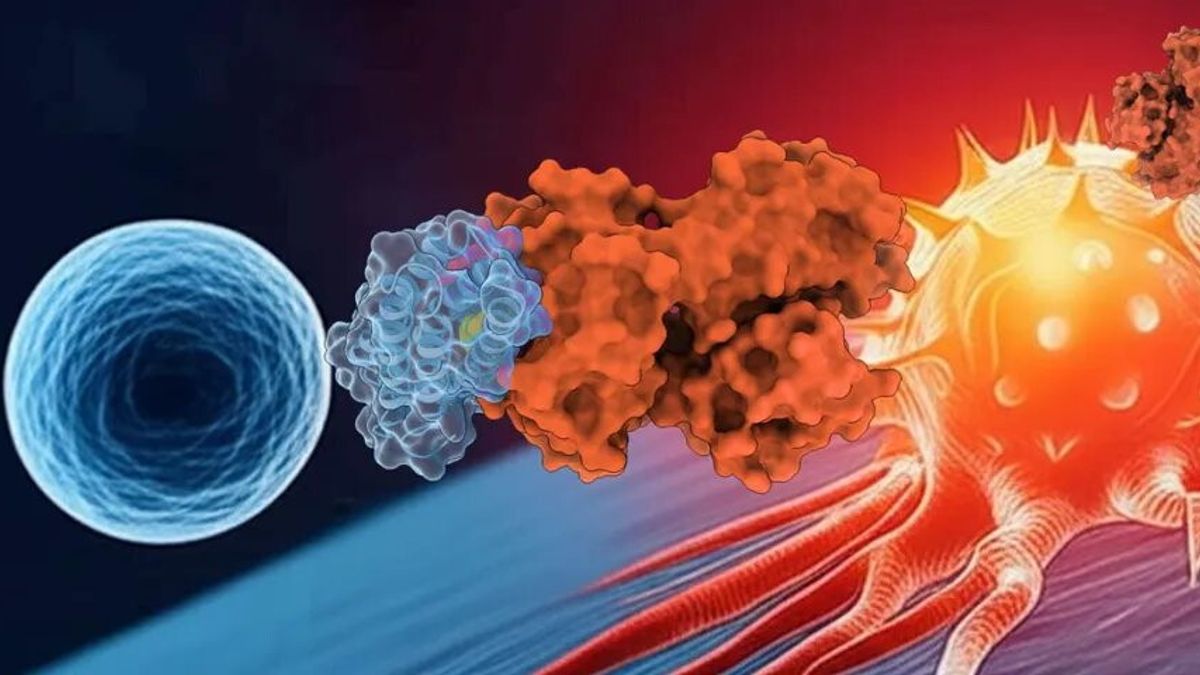
© Ufficio stampa
Un'innovazione che potrebbe rivoluzionare la lotta contro il cancro arriva dal Politecnico della Danimarca: un'intelligenza artificiale è riuscita a progettare in meno di sei settimane recettori molecolari personalizzati in grado di guidare le difese immunitarie direttamente sulle cellule tumorali. Il risultato, pubblicato sulla rivista Science, promette una nuova generazione di cure su misura, più rapide e precise. I primi test clinici sull'uomo sono previsti entro cinque anni, ma la velocità di progettazione già ottenuta rappresenta un cambio di paradigma nella medicina oncologica.
Nuova frontiera per l'immunoterapia
Il cuore dell'innovazione è una piattaforma sviluppata dal team di Timothy Jenkins presso il Politecnico della Danimarca. Questa tecnologia, grazie all'utilizzo avanzato dell'intelligenza artificiale, è in grado di generare recettori molecolari capaci di riconoscere e attaccare le cellule tumorali. Il processo tradizionale per identificare tali recettori può richiedere mesi, se non anni, perché necessita dell'analisi del sistema immunitario di ciascun paziente. Invece, con la nuova piattaforma, il tempo si riduce drasticamente a 4-6 settimane. Il meccanismo sfrutta dati biologici preesistenti e modelli predittivi per sintetizzare molecole con alta affinità verso antigeni tumorali specifici. Secondo Jenkins, questa velocità apre le porte a trattamenti oncologici molto più personalizzati e tempestivi.
Precisione che fa la differenza
La tecnologia è stata testata su un antigene chiamato NY-ESO-1, presente in una vasta gamma di tumori. I recettori progettati hanno dimostrato non solo una straordinaria efficacia nel colpire le cellule tumorali, ma anche una notevole selettività, evitando le cellule sane. Questo rappresenta un vantaggio cruciale rispetto ad altri approcci immunoterapici, spesso associati a effetti collaterali dovuti a un attacco poco specifico. Il sistema sviluppato agisce come un "GPS molecolare" in grado di guidare le cellule T verso il bersaglio, riducendo il rischio di reazioni avverse. I risultati dei test in vitro indicano che il meccanismo potrebbe essere adattato ad altri antigeni tumorali, aumentando così le potenziali applicazioni cliniche della piattaforma.
Tempi record e prospettive cliniche
Nonostante i risultati incoraggianti in laboratorio, serviranno ancora circa cinque anni per vedere i primi test clinici sull'uomo. Gli esperti prevedono che, una volta approvata, la terapia seguirà un protocollo simile a quello delle attuali CAR-T: estrazione dei linfociti del paziente, modifica in laboratorio e reintroduzione nel corpo. La differenza sostanziale sarà nei tempi e nella precisione. I trattamenti personalizzati potranno essere sviluppati su misura nel giro di poche settimane, offrendo soluzioni mirate anche per pazienti con tumori rari o resistenti. Secondo Jenkins, questa potrebbe essere una svolta per migliorare i tassi di sopravvivenza e la qualità della vita dei pazienti oncologici.
Lo scenario e le implicazioni future
L'applicazione dell'IA nella progettazione di terapie antitumorali apre scenari inediti per la medicina personalizzata. La possibilità di creare molecole su misura in tempi brevi significa anche ridurre i costi della ricerca e rendere le terapie accessibili a più pazienti. Inoltre, l'utilizzo di minibinder sintetici progettati anche senza informazioni strutturali complete dell'antigene amplia il ventaglio dei bersagli terapeutici disponibili. Questo approccio potrebbe estendersi in futuro anche ad altre patologie complesse, come le malattie autoimmuni. I ricercatori sottolineano però che sarà fondamentale una regolamentazione chiara e una validazione rigorosa dei protocolli per garantire sicurezza ed efficacia.
Cos'è la medicina personalizzata
La medicina personalizzata è un approccio terapeutico che tiene conto delle caratteristiche genetiche, biologiche e ambientali di ciascun paziente. L’obiettivo è fornire cure su misura, più efficaci e con meno effetti collaterali rispetto ai trattamenti standard. In oncologia, le terapie personalizzate si basano spesso sulla profilazione genetica del tumore per identificare mutazioni specifiche e scegliere farmaci mirati. Tra le tecniche giù operative figurano l’immunoterapia a base di linfociti T ingegnerizzati (CAR-T), la somministrazione di inibitori a bersaglio molecolare e l’uso di test genomici per prevedere la risposta ai farmaci. Questo approccio è in rapida espansione grazie alla disponibilità crescente di dati genomici e all’integrazione con strumenti di intelligenza artificiale capaci di analizzare enormi moli di informazioni cliniche.
Altri studi: l'IA protagonista in campo medico
Non si tratta di un caso isolato. Negli ultimi mesi, l'intelligenza artificiale si è affermata come uno strumento centrale nella ricerca medica. A Stanford, il progetto MUSK integra dati clinici e immagini patologiche per prevedere l'efficacia dei trattamenti oncologici. La startup Insilico Medicine ha invece sviluppato un farmaco antitumorale progettato interamente da IA, già testato con successo in laboratorio. Al MIT, il modello CellLENS identifica sottotipi cellulari nei tessuti, migliorando la diagnosi e la scelta delle terapie. Altri studi, basati sull'analisi di dati multi-omici, permettono di suggerire trattamenti personalizzati con spiegazioni dettagliate. Tutti segnali di una trasformazione profonda, in cui l'IA accelera l'innovazione sanitaria con risultati concreti.


